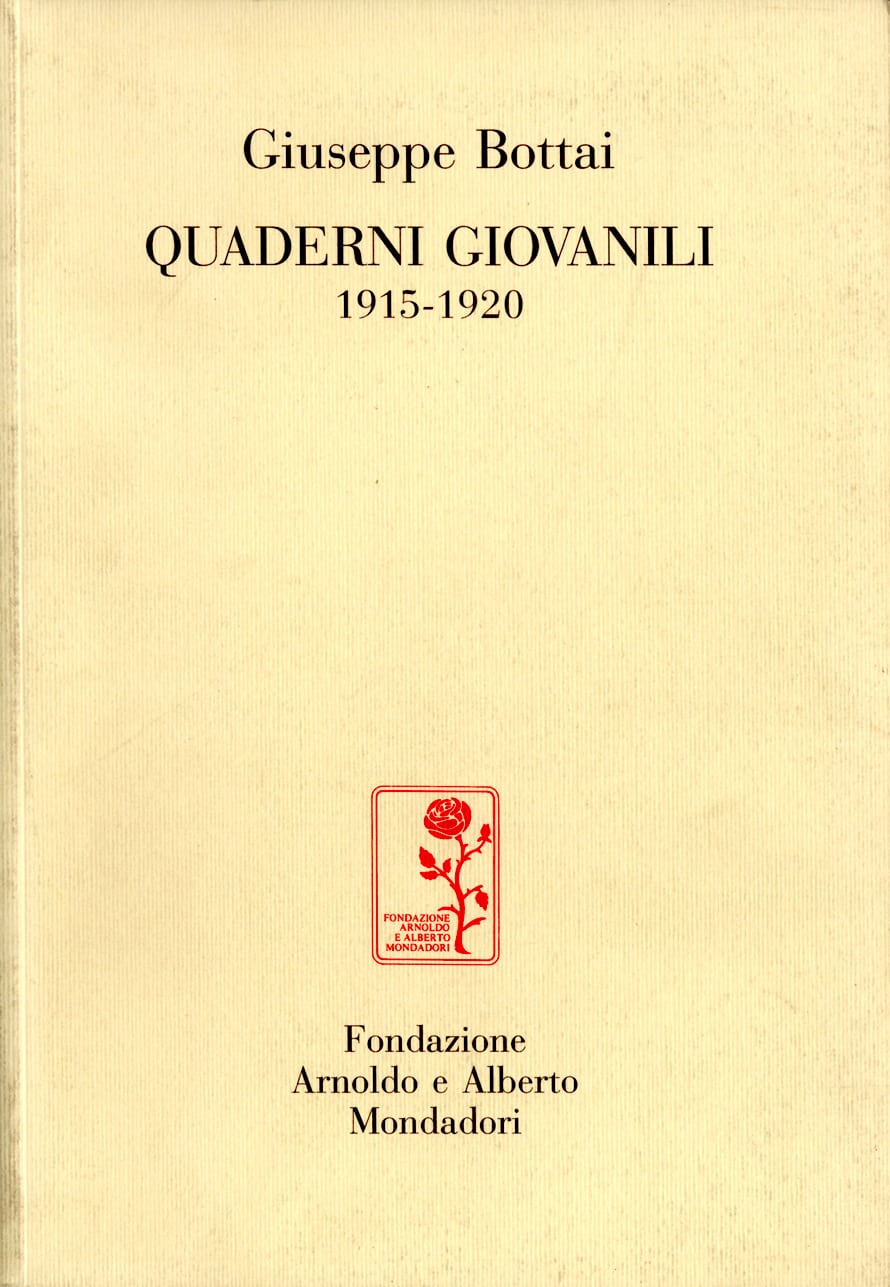Dalla Prefazione di Stefano Mecatti
Perché “Quaderni” e non “Diario”
La “grande guerra” è stata una fucina di scrittura. Come non fissare il ricordo di un evento così eccezionale? Non registrarne i momenti più significativi nell’atto stesso del loro accadere? Non costruire un colloquio almeno con se stessi, intervenendo a caldo con note giudizi riflessioni? Fu l’eccezionalità di quell’esperienza, ma anche la costrizione al silenzio a spingere i soldati a scrivere. Il 1° settembre 1915 Giuseppe Bottai appena ventenne, giunto da poco volontario al fronte, comincia a stendere quaderni che dedica alla sua giovane fidanzata Nelia Ciocca e, sia pure con interruzioni e lacune, continua a scriverli fino al 1920, coprendo l’intero arco del primo conflitto mondiale. Cosa rappresentano per lui, giovane sottotenente che dal Colle di Lana inizia il suo viaggio attraverso la guerra? Lo dice a chiare lettere sin dal frontespizio del primo quaderno: queste pagine saranno “strappi di serenità e di dolce pensiero”. Pagine, dunque, sottratte alla guerra. Ma la sua crudezza contraddice subito le sue buone intenzioni e lo scaraventa nel vivo di una sequenza bellica, ripresa quasi cinematograficamente: “Ed ecco la guerra. Rombi nell’alto, spaventosi, atroci, strazianti, voci, lunghe, strascicate, terribili, che dilaniano l’aria” (Q. 1° settembre 1915). In quel “trambusto febbrile”, in quel paesaggio di morte, l’unico esempio da seguire per contrastare l’impeto e la tensione della guerra è quello delle vette “lontane, misteriose”, che con la loro serenità “sembrano sorgere da un abisso di pace”. Solo la natura, nella sua distanza e imperturbabilità, può insegnare a resistere. L’apprendistato è difficile, anche perché la guerra, pensata come guerra di movimento, si trasforma subito in guerra di posizione e viene combattuta nelle trincee, in cui del mondo naturale non resta che la nostalgia. Non c’è scampo: la sua presenza occupa tutto il campo visivo. Si può cancellare solo con uno sforzo d’astrazione, concentrandosi mentalmente sulla natura e sull’amore.
Ma a cosa danno vita questi quaderni fino ad oggi rimasti sepolti ? Compongono un giornale, un taccuino di guerra, un diario intimo e privato? I quaderni redatti dal giovane Bottai sono disomogenei. Soltanto nel ’15 e dal settembre alla fine del ’16, allorché vengono scritti al fronte, portano i segni inequivocabili di un discorso in atto, che si fa giorno dopo giorno. Paradossalmente, solo quando il fulcro del discorso è la guerra essi, seguendone il ritmo tra fatti di trincea e azioni sulla linea del fuoco, istantanee di villaggi distrutti e aneddoti eroici o banali, assumono un andamento narrativo.
Dal 21 settembre 1915, quando viene ricoverato all’ospedale di Agordo, la guerra comincia a sentirsi solo direttamente negli strappi di nostalgia per i soldati o nel desiderio di tornare a combattere “lassù, tra i monti”; e la scansione diaristica finisce per segnalare soltanto le date delle prime composizioni in versi. D’ora in poi, poesie o prose poetiche saranno sempre più frequenti. E’ l’intervallo della malattia a dare impulso alla dizione poetica e a quell’apprendistato di serenità e saggezza che il giovane Bottai continua sognare. In questo senso potremmo definire il diario, nel suo complesso, un diario di formazione e leggervi il quotidiano esercizio a mantenersi fanciulli pur nella tragedia della guerra; ad acquisire lentamente il necessario distacco dagli eventi, prendendo a modello la natura (“le vette imperturbabili nell’infuriare della battaglia”); a frapporre una salutare distanza dalle passioni immediate. Si trattava di salvare il proprio mondo intimo sempre più assediato da una guerra-macchina; di sottrarsi almeno mentalmente alla vita da talpe nelle trincee, agli spostamenti senza scampo, all’umiliante ripiegamento nelle retrovie. Di quest’acquisizione di fermezza potremmo descrivere la parabola che, negli anni dell’immediato dopoguerra, culmina con la “noncuranza” leopardiana. L’itinerario ha inizio nel ’15 con esempi modesti; prosegue con “l’intermissione” del proprio destino attraverso il riso, che è come il segno della dimenticanza di se stessi e si completa con la conquista dell’ironia. Sarà il Leopardi maturo, che trova conforto “ridendo dei nostri mali”, a fungergli da modello: il Leopardi delle Operette morali da cui trarrà una legge di vita. I quaderni bottaiani del ’15 e del ’16 sono costellati di aneddoti e di interrogativi sulla morte. O, viceversa, di pause meditative e di stupore di fronte all’irriducibilità della vita. Di quella vita che pur tra le macerie, resiste e diventa per i soldati la cosa più importante.